Poesie di Lucrezia Marinelli
Disse Lucrezia (Poesie)
Da: "Sospiri e palpiti, scrittrici italiane del seicento"
Introduzione
Nel magico tramonto dell’età dell’oro che Venezia vive a fine Cinquecento e che stringe il suo Rinascimento alle sofisticate culture del Nord, alle Fiandre come alla Praga di Rodolfo II, il dibattito di idee è quanto mai vivo, ed intenso ed originale è il contributo femminile.
Lucrezia, di famiglia intellettuale, è una delle giovani sagge che possiamo immaginare ci venga incontro da un dipinto di Paolo Fiammingo, accompagnata ad altre gentildonne lungo una laguna silenziosa e dorata oppure intenta in villa tra concerti e feste a discettare con arguzia delle virtù femminili.
Con lucidità e coraggio, Lucrezia sa affermare la dignità del sesso femminile in polemica con i Donneschi difetti di Giuseppe Passi (1599) e tesse quale argomento vincente una sottile corrispondenza che nell’esperienza della donna si stringe naturalmente tra “eccellenza del corpo” e “nobiltà dell’anima“. Singolare è, nel gusto retorico dell’epoca, la sua attenzione linguistica:
“O che nomi rari, meravigliosi e degni: già che dinotano e significano tutte quelle meravigliose eccellenze che nel mondo si ritrovano e ritrovarsi possano. Ceda pure a voi ogni altro nome, già che denotate produttione e generatione; fuoco e splendor di mondo; anima e vita; raggio divino e celeste; delicatezza e clemenza; e finalmente dominio e signoria”.
Lucrezia affascina per la sua vocazione intellettuale, per la cultura. Ma altrettanto toccante è vedere questa giovane intellettuale seguire la sua vena di poetessa e cimentarsi nell’epica e tradurre nell’Enrico ovvero Bisanzio acquistato desideri e preoccupazioni di Venezia per l’oriente. A rivendicare un antico orgoglio, e ad allontanare così brutti presentimenti, la Crociata fatta rivivere nel poema è la quarta: ed è infatti questa impresa, condotta tra il 1202 ed il 1204 dal vecchio doge Enrico Dandolo, ad aver segnato l’avvio della grandezza di Venezia.
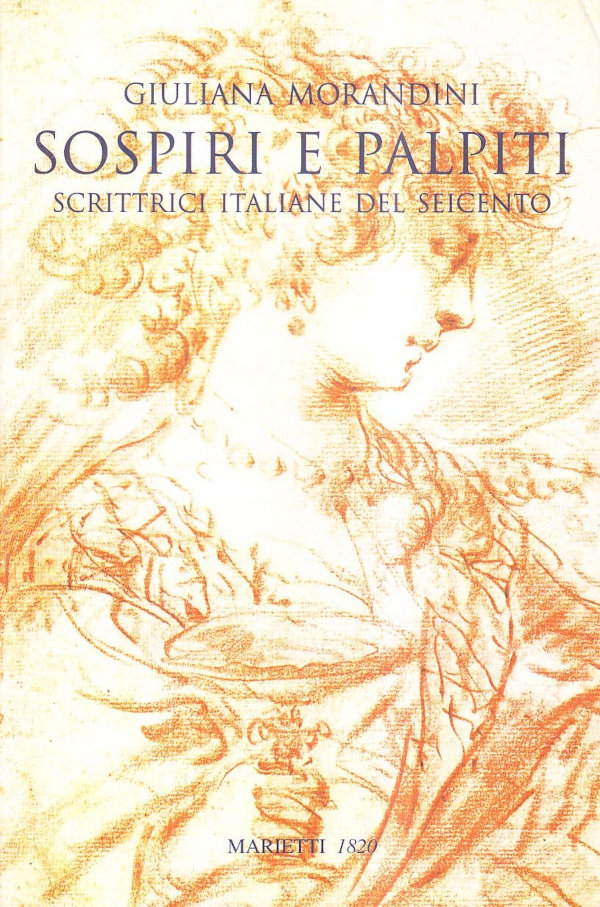
C’è dunque in Lucrezia l’ambizione di scrivere una gloria, con negli occhi le immagini di Tiziano e più di Veronese e Tintoretto, i pittori della Serenissima che cantano stagioni di vittoria anche se le imprese sono ormai velate dalla patina del tempo e presenti solo come nostalgia. Egualmente l’entusiasmo della giovane poetessa si intinge di malinconie, e già la scelta del protagonista, il doge anziano e stanco, è sintomatica di come il disegno si sviluppi fragile, con un ritmo che di epico ha il suono più che l’impeto di una passione accesa.
La predilezione di Lucrezia, va tutta al Tasso, ed è mirabile al riguardo come sappia, nella rarefatta trama, incastonare episodi di squisita penetrazione emotiva.
Bellissima è la storia d’amore sfortunata di Clelia e Lucilio (canto IV, strofe 48-86, e canto V, strofe 28, 33, 5O): Lucilio parte per la Crociata nonostante il presagio sfavorevole e va incontro alla tempesta; assiste poi, in versi di disadorna drammaticità, al crescere implacabile del suo naufragio. Intanto Clelia ha in sogno l’immagine dell’amato e si precipita alla spiaggia, ne raccoglie il corpo e muore con l’amante tra le braccia. Motivo bellissimo che anticipa il gusto romantico ed ha quasi in certi movimenti l’aria del melodramma, e sembra, oltre che rendere il clima della passione d’amore, riuscire emblematico di un nuovo genere espressivo.
Egualmente sfortunata è la storia d’amore di Areta e Corradino, con l’affannosa ricerca da parte di Areta del corpo dello sposo sul campo di battaglia: un brano dove gli accenti preromantici fondono alla lezione del Tasso la memoria virgiliana di Eurialo e Niso. Altri episodi di grande fascino offre il poema, con l’immersione degli eventi in scenari di magico incanto di natura indagata con attenzione moderna: in queste atmosfere sognanti Idilia giunge presso il pastore (canto XI) e, in una riunione di dame e cavalieri, il dotto Irenio da una lezione di astronomia, evocando i moti del sole e la via lattea (canto XIII, strofe 57 ss.).
L’attenzione sentimentale che Lucrezia usa per tendere la trama epica muove anche le sue conflittive rime d’amore egualmente pervase di un senso panico naturale. Ed è la stessa temperatura di sentimenti che cerca nel poema mitologico Amore innamorato e impazzato e nelle operette religiose, dove, sempre in ottave, il ritmo del canto cortese evoca le vie altrettanto epiche della fede, facendo rivivere, come avventure dello spirito, la vita di Maria Vergine, e le storie di santa Colomba, di santa Giustina e di san Francesco.
Intatta rimane, sia che avvivi trame di guerra, sia che accenda temi devoti, la tensione d’amore:
“Se io ardo, oimè, se io moro,
dicanlo que’ begli occhi
quai fur le mie faville, anzi il mio foco”.
Un ardore dolce, nella luce malinconica della serenissima, “i chiari lumi in lucido oro affisi“.
Poesie
Mesto Lucilio vede infeste l’onde,
sdegnoso il cielo, e l’aere oscuro e nero;
or scender tra voragini profonde
il pino, or sovra l’acque andar leggiero:
Sospira gravemente, e non asconde
il dolor del suo petto acerbo e fero,
Si pentisce; ma tardi assai si duole
che non restò di Clelia a le parole.
[…]
Da le nubi e dal mar, che in alto ascende
privo è rimaso d’ogni luce il cielo;
che fa a mirarlo in volto il cor di gelo. –
Ecco tra l’ombra il vento desta e accende,
e tra pioggia e tra nebbie acceso telo;
e la rapida fiamma arde e riluce,
che il mal si vede e il mondo empie di luce.
[…]
Clelia, poi che dal fermo lido sciolse
l’infausta nave, e dispiegò le vele
l’infelice Lucilio, e fidar volse
la cara vita al mare empio e crudele,
pallida e fredda ognor pianse e si dolse,
empiendo il ciel di voti e di querele,
e, pria che morto, il pianse morto, e vide
con qual ferro il dolor l’anima ancide.
Già fugge il cibo, abbandonata e sola,
oppressa il cor da i suoi pensier mortali,
al commercio d’altrui si toglie e invola,
e nutre il cor de’ suoi gravosi mali.
Dolce conforto lei non riconsola,
nè ragion racchetar può i sensi frali,
e del martir sotto il gravoso pondo
geme, chiamando il nome a sè gìocondo.
Clelia se in aria l’aura i fiati move,
e il mar rincrespi e scota foglia o fronda,
trema, e le par che folgorando Giove
d’intorno anneri e il mar turbi e confonda,
ma, quando acerbo il ciel fulmina e piove,
spirano i venti in alto sbalzan l’onda,
fredda sopra il suo letto stesa giace,
languida geme e sospirosa tace.
Come d’alpestre vento ode il rumore
le son saette al cor di mal presago;
Sembra un’ombra d’angoscia e di terrore,
simulacro infelice, orrida imago;
Le bianche gote di dolente umore
riga, da cui fuggito è il color vago,
e l’aere dolce del sereno volto
in oscura tristezza in tutto è volto.
Se ella ode calpestio, se venir vede
paggio o guerrier verso il suo regal tetto
pallida e sbigottita un messo crede,
che dica in mar sommerso è il tuo diletto;
Mossa da tal pensier che il cor le fiede,
e di perdita tal dal rio sospetto
mira e d’ogni salute già dispera
torbide l’acque e l’acqua oscura e nera.
Udir parle e veder moto e tumulto
del mare irato, e il flutto atroce e fero,
e de gli venti il repentino insulto,
e d’ogni speme privo il buon nocchiero;
Vedere il caro suo squallido e inculto
chiamar soccorso dal celeste impero;
e quel che più l’aggrava d’aspre some,
Ë che chiami, le par, di Clelia il nome.
Così s’incontra, e interna il cor turbato
in tal pensier, che già le ha il sen diviso,
che sparge di un sudor freddo e gelato
le impallidite rose del bel viso.
Se non avesse il pio soccorso a lato
de le donzelle, quai con saggio avviso
sostentan lei, cadrìa, ma la pietade
de l’amica bontà fa che non cade.
Intanto, ecco la notte e intorno il mondo
stringea tra il fosco orror de l’umide ali,
de le cure noiose il grave pondo
il sonno accheta, a i sensi infermi e frali:
ma fine a lei non dà lieto e giocondo,
trafitta il cor da dolorosi strali,
e notte e giorno cresce il fier dolore
da mille parti al combattuto core.
Mezzo e più del cammin già scorso avea
notte, e verso l’occano il volo apria,
e il candor d’oriente si vedea
vincer con la sua luce l’ombra ria,
quando a costei, che in pianto si dolea
de l’occulto infortunio, qual solia,
orribil sogno il sonno egro discopre;
quel ch’era incerto, e certo e vero scopre.
A quell’afflitta mente il bel Lucillo
mostra col capo chin, languido e smorto,
non già simile a sè, quando partillo
brama d’onor dal suo paterno porto;
Che per seguir d’Enrico il gran vessillo
rimase in mar esasperato absorto;
ma d’acque il crin stillante, orrido il volto,
già latte ed ostro, grazioso e colto.
Riconosci il tuo caro, o Clelia mia,
dir le parea, che in mar rimase spento?
Guardami! io desso sono, or saggia e pia
dà tomba al corpo e fine al tuo tormento:
Potenza ignota e il Ciel cortese invia
al lido tuo, nè a te porga spavento
il miser corpo mio, se lui vedrai
da quel che di già fu, mutato assai.
E prego te, se alcun mio prego mai
ebbe forza appo te, che questo vaglia.
Mentre era in vita sai, quanto t’amai,
nè a l’amor tuo credo che alcun s’agguaglia;
Che intatto ancor lo serbi, nè giammai
fuor che di me novello amor t’assaglia,
Io t’amo e adoro, nè fia d’arder priva
fiamma d’amor, che ancor ne’ morti è viva.
Ella piange al suo pianto e grida e dice,
mentre per ritenerlo apre le braccia:
Ben de l’anima mia teco infelice
me infelice condurre ormai ti piaccia:
che a me senza di te viver non lice .
Ch’io viva e il mio Lucillo estinto giaccia,
ah! ver giammai non fia: s’era tua vita
malgrado mio da me farai partita?
E se il dolor lo spirto egro e languente
non rapirà con dispietata mano,
o nero tosco, o ferro empio e tagliente;
Perchè ti segua, a me ‘1 farà lontano.
Mentre così dicea, lasso e dolente
con dirle: Addio, si sciolse in aere vano,
Come talor veggiam fare se l’ira
di superbo Aquilone in essa spira.
Il dolor, il timor, il sogno e il sonno
scacciò da sè con un terribil grido,
come colui che de la vita donno
Vede già fatto il suo nemico infido;
Perchè i freni di ragion regger non ponno
più la bell’alma sua, già caro nido,
qual forsennata l’aurea chioma e il seno
strazia e percote, i gridi il tutto han pieno.
Di manto negro e nubiloso cinta
sporgea l’alba tra nubi atra e pensosa,
non di porpora, o d’or fregiata e pinta
ma turbata, dolente e lagrimosa;
Lassa pendea di pallidezza tinta
per pietade di lei mesta la rosa;
Piange, non canta i suoi gravosi danni
l’augel tra boschi, e i suoi gravosi affanni.
Esce stracciata il crin, livida il volto,
sparsa di pianto, dal real soggiorno,
Vede il mar procelloso, al ciel rivolto
al fine suo di nero avvolto intorno:
Portar pel vento impetuoso e stolto
per lei dolente e sospiroso giorno
Teme trovar chi cerca, e chi vorria
veder, teme veder chi pur desia.
Con mesta schiera di serventi ancelle
la mestissima donna guata e mira
Giunta al pelago irato, oh cielo! oh stelle!
oh vista! oh duol! che ‘1 cor l’ange e martira:
Molle, languido e freddo sopra quelle
arene, vede quel per cui sospira,
vede il suo bene e riconosce il viso
amato e caro, ond’è il suo cor conquiso.
Non si piegò, cadde, tratta dal pondo
di quella angoscia, che nel cor ritiene,
Vede placido sì, ma non giocondo
Il volto a lei cagion d’amare pene.
Vede implicato e intesto il suo crin bondo
D’alghe, di giunchi e di minute arene,
Il mira e tace e par che pensi e poi
Boc’apre a detti incerti i labbri suoi:
Oimè! qual ti riveggio? oimè! son queste
Chiome d’or fin, che m’allacciaro il core?
Queste le luci, oh cielo! oscure e meste,
Ch’eran riso, gioir, grazia e splendore?
Son quelle, oimè! che le mie voglie oneste
Acceser prima di bramato ardore?
or torni morto a portar morte a quella,
Ch’eri sua vita? ahi sposo! anima bella!
Che giovò, oimè!, che del futuro fosse
Infelice indovina, ed io temessi
De l’orgoglioso mar l’ira e le posse
Trepida l’alma e ghiaccio il petto avessi?
Se vietar non potei quel mal che mosse
Te, fido mio, da’ miei pudici amplessi.
Fu il Fato e il Cielo avverso, che in te volse
Il cor molle in diaspro e i lini sciolse.
Te non accuso e del mio afflitto petto
Vista orribile e strana, unica speme;
Sento che m’erri intorno, o spirto eletto,
E intendi ed odi queste voci estreme:
Ma teco tosto vengo; in questo detto
Bassamente intra sè mormora e geme.
Si piega, e il collo al caro amante abbraccia,
Dà freddi baci a la gelata faccia.
Non così avidamente edera cinge
A l’amato marito il collo adorno;
Nè cupida così circonda e stringe
Vite amorosa il caro tronco intorno;
Come costei, che già al morir staccinge
Ne l’amplesso di morte, o infausto giorno
Mesto mirasti di duol aspro ed empio,
E d’amor e di fe’ sovrano esempio.
Nè più rivolse al cielo i lassi lumi;
Nè sospirò, nè si percosse il seno;
Nè si vider da gli occhi amari fiumi
Scender per volto a far molle il terreno;
Nè tremò, nè si scosse: ma costumi
Casti e colmi d’amor scoperse a pieno,
Mentre al’6racciato il tiene cangia stile,
s’aggela e affredda, a lui divien simile.
Nè già le helle e delicate braccia
da quei nodi amorosi alcun può sciorre
Giunta ha la faccia a la hramata faccia,
nè concesso è di muoverla o disciorre.
Oh miracol d’amor! Chi fia che ‘1 taccia?
E non tra le altre sue queste ancor porre
supreme meraviglie, Amor congiunse
quei che del Fato ira e furor disgiunse.
Pietosissimo Ciel, quando al dolore acerbo,
il fin con la sua morte desti,
e col suo caro e tanto amato amore
dopo tanto martir lei congiungesti.
(Enrico ovvero Bisanzio acquistato, Venezia l635, canto v, strofe 31-56)
Mentre le donne e i cavalieri assisi
a le gran mense sono, e che d’intorno
i chiari lumi in lucid’oro affisi
destan tra l’ombre oscure acceso il giorno,
tra scenici apparati e lieti risi
d’immortal lauro allor comparse adorno
Il dotto Irenio, che’l suo canto accoppia
a dolce cetra, ed il piacer raddoppia.
Cantò del sol le maraviglie e i moti,
come a noi stavvicini inerbi e infiori
la piaggia e il monte, e come desti e scoti
li semi occulti, avvivi ed innamori
E come tolto a noi, porga a remoti
co’vivi raggi suoi grazie e favori;
Perchè lunghe le notti e i giorni brevi,
e adorni il secco pian manto di nevi.
Per qual cagion biancheggi il bel sentiero,
che di Giove al palagio i Dei conduce;
Perchè Venere pia, Marte severo
con crudo e vago aspetto in ciel riluce;
Perchè minacci nel superno impero
ai naviganti d’orion la luce;
Perchè non possan l’orse il caldo ardore
spegner de l’onde nel salato umore
Qui si tacque il cantor, stettero al canto
le donne e i cavalier stupidi e ai detti
[…]
(canto XIII, strofe 56-59)
Areta intanto caute orecchie porge,
se da la pugna il caro amante riede;
del suo ritorno impaziente, or sorge,
e qua, là desiosa or spazia, or siede;
nè del suo mal la misera s’accorge,
nè di tanta sventura il cor s’avvede.
Ecco un Messo anelante, in volto esangue,
tinto e cosparso di sudor di sangue
che dice mesto (ha in fronte il duol dipinto
per l’annunzio che porge tristo e strano):
“Corradino il tuo sposo è in campo estinto;
quel che cotanto amasti or giace al piano;
quel che di tua beltà fu in modo vinto,
cui parve ogn’altro amore indegno e vano,
quel del qual fusti ognor pace e conforto,
steso Ë tra gli altri, lacerato e morto”.
Come al cader del Sol dispoglia il mondo
di tanti vaghi aspetti il bello e ‘1 grato,
freddo e oscuro e orrido e infecondo
sembra, e pien di spavento, orbo e gelato,
tal quant’era di lieto e di giocondo
e di caro e di regio e di lodato
sparve a i detti funesti, e restò solo
tristezza in essa, pallidozza e duolo.
Rimase tal, qual resta quello al quale
ferro crudel da man nemica è sceso,
e rapirsi lo spirto, e di mortale
piaga nel cor da quel si senta offeso;
tace, sta immota, a lamentar non vale,
chè del travaglio è troppo grave il peso;
nè 1 suo penoso affetto è in pianto sciolto,
nè in sospir grave è ‘1 suo dolor disciolto.
Depon tornata in sè l’odiate some
de le pompe già in pregio, or, gemme, ed ostro;
copre di nero vel le belle chiome;
empie di pianto e strida il regio chiostro:
nè mai die’ pace al suo penar; ma come
Febo lasciò pietoso il mondo nostro,
le lasse membra involse in rozzi panni,
segno evidente de’ suoi gravi affanni.
E con due fide sue che ognora avea,
di gentil sangue, a’ suoi servigi pronte,
lascia l’amica terra, e non temea,
tale ardir gli dà amor, ch’altri l’affronte;
per l’ombra quinci e quindi s’avvolgea,
per ritrovar di sua speranza il fonte:
chi a te possa agguagliar di pianto aspersa,
Niobe forse in lagrime conversa.
Stese, fuggito il giorno, oscuro velo
notte, onde il tutto n’era a negro involto;
da nubi usciva a far più bello il Cielo
la Luna, vaga il piè, candida il volto,
che chiari raggi e rugiadoso gelo
dal sen versava, e dal crin biondo e colto;
onde emula del dì parea l’oscura
ombra, d’orror ripiena e di paura.
Coperte in ogni parte il campo vede
di corpi tronchi, discipati, e morti:
questi incise ha le braccia, quegli un piede,
nè si distinguon da gl’imbelli i forti,
e alcun moril ondo ode che chiede
a l’alma inferma gli ultimi conforti;
fitto alcun ne la terra ha l’elmo, e vivo
non può ritrarsi, e d’ogni aita è privo.
Là tra ‘1 miscuglio de le estinte genti
cerca quella infelice il caro amante;
e tra pallide faccie e volti algenti,
alfin trova di lui l’egro sembiante;
gli occhi e i color del viso orridi e spenti
conosce al lume de la luna errante:
cade sopra di lui, freddi sudori
fregian del viso i pallidetti fiori.
Ohimè, quai furo i pianti, ohimè, quai furo
i sospiri, le angosce, e le querele!
Chiama le stelle, e ‘1 mondo acerbo e duro,
sua fortuna, ed il fato empio e crudele;
mirando il ciglio, quasi un Cielo oscuro,
che fu lucido sì del suo fedele,
facca pietoso l’aere: attento e fiso
ne stava a gli atti di quel nobil viso.
E da’ piovosi Soli in lui diffonde
nembo e pioggia di lagrime dolenti;
nè al bianco seno, od a le chiome bionde
perdona: strazia e frange ambo innocenti;
tra i notturni silenzii egra confonde
al mesto pianto dolorosi accenti,
li quai dal lasso petto escono furore
messi lugubri del suo gran dolore:
´O del mio core anima eletta e cara,
o de la vita mia più degna parte,
ove è la fè promessa? Ah sorte amara,
a la tua sposa, ahi, fur parole sparte;
giurasti di guardarti in quella amara
guerra, a contrasto dell’orribil Marte,
per non offender me, che nel tuo petto
avea di casto amor nobil ricetto.
Come possibil è ch’io viva e spiri,
se chi fu l’alma mia qui giace estinto?
Non vivo, no, da crudi aspri martiri
lo spirto fu da questa spoglia spinto;
or lo infelice d’Erebo nei giri
s’avvolge e aggira dal dolor sospinto..
Ahi, quanto questa mente erra e vaneggia!
Pur è morto, e io, viva, sia che ‘1 veggia?
Ed io pur vivo, come tu pur sei quello
onde li sensi miei dolce avean vita,
che morto miro, e ‘1 volto amato e bello,
squallido, in cui s’è ogni beltà smarrita.
Ov’è ‘1 lume de gli occhi, e del capello
L’oro vivace, e de l’età fiorita
i bei ligustri e le vermiglie rose
che ne le belle guancie Amor ripose?
Ben mi percosse il cor mortal affanno,
quando apparir le Veneziane antenne;
si scosse l’alma, e del futuro danno
presago il cor trista sembianza dienne;
ohimè, troppo indovina, ah miser anno,
rea stagion, giorno infausto; il cor sostenne
sl crudo incontro, che ‘1 mio ben presente
raddolcia ‘1 fel di quella amara mente.
A che viv’io? la vita m’era a grado,
quando più fortunata al mio Signore
spirava amata; or perchè al mondo bado?
Poichè m’è l’aere, e ‘1 Sole ombra ed orrore;
nè ‘1 mio core infelice persuado
a mirar più di lui grazia e splendore!
Da’ cani sia sbranato, e insepolto
Rimarrà l’amor mio nel sangue involto?
Ah! ver giammai non sia, pria restin queste
membra odiate a mille helve in preda;
ma questo sen sia a le sue belle e meste
seggio, ove ancora egli s’appoggi e sieda”.
Così dicendo, a l’opre atre e funeste,
perchè quanto desia, tanto succeda,
con le mani il solleva, e tosto quelle
a l’oprar dan favor, pietose Ancelle:
e dal soave pondo oppresse, i passi
volgono al loro ospizio usato e caro.
Urlo, latrato, o dirupati sassi,
non pon tardar la via che incominciaro;
e dove il marital suo letto stassi,
gementi e sospirose lo posaro;
quivi di nuovo al lamentar si volse,
e quasi in acqua il vago corpo sciolse
(canto XVIII, strofe 21-41)
O Boschi, o piaggie apriche,
d’Austri oscuri orrori,
o voi Aure, che in aria errando andate,
o Cielo, o genti amiche,
o voi correnti umori,
che il tesoro di Perle al Mar portate;
Deh, almen qualche pietate,
di me vi mova, e a questi estremi accenti
porgete orecchie, e a questi pianti,
e sospiri mesti,
Alle pene, alle note, a’ miei tormenti,
ch’or fa del mio morire
anzi morte l’essequie il mio martire.
Or che si mira intorno
di purpurea bellezza
tinta la rosa e di candore il giglio,
e ride il Cielo adorno
con celeste vaghezza
di novello color bianco, e vermiglio,
più crudo il ferro artiglio
sento d’Amore, e fiamme, e lacci, e strali
ferirmi, ardermi il petto:
E pur qualche diletto
proverei fra tanti aspri, e duri mali,
se d’amor dolce un raggio
spiegasse nel mio volto il cor selvaggio.
Più che del Sole i lampi,
e delle stelle il lume
splendon le ricche chiome, e gl’occhi amati:
nè rosa in questi campi,
si vede, o in Cigno piume,
che uguagli del bel viso i fior beati,
non di pietate ornati,
ma d’alta crudeltà, di fiero orgoglio;
Ond’io per ogni riva,
o mia terrena diva,
dura ti chiamo, e me ne affliggo e doglio;
onde alla pena mia
vien molle il marmo, e ogn’aspra Tigre pia.
O vaga, o lieta, o bella
più che sorgente Aurora,
e più ferma che scoglio a’ miei sospiri;
Vera d’Amor rubella,
non ami chi t’adora,
ingrata Jole, e perchè in me non giri
le tue luci, e non spiri
di mansueto Amor fiamma celeste,
Ch’io poi, più che mai lieto
da tale stato inquieto
passerei a’ piaceri, a’ risi, a’ feste;
e come a Dea conviensi
il cor ti sacreria tabelle e incensi.
S’io ardo, oimè, s’io moro,
dicanlo que’ begli occhi
quai fur le mie faville, anzi il mio foco:
Io, qual Cigno canoro
moro cantando (e scocchi
Amor quanto vuol strali) il tempo, e il loco
ov arsi, e il riso, e il gioco
di lei, che me fuggendo Amor offende;
Ma s’egli quel bel seno
tocca di sdegno pieno,
con foco di pietà, ch’arde ed accende,
tardi delle mie doglie
te ne dorrai, crudel, fra nere spoglie.
Itene al cor di ghiaccio
o mie calde querele,
rotte dal vento de’ sospiri accesi,
e quel foco, e quel laccio
narrate al cor crudele,
che mi stringe, arde, infiamma, e come offesi
me per amarla, e ascesi
a sceglier sue 6ellezze peregrine,
acciochè fosser scorte
certe di quella morte
che faran queste membra egre e meschine;
e ciò pur vedranno oggi
questi monti, este valli e questi poggi.
Poich’io rimarrò estinto,
Canzon, nata di pianto,
tu farai noto all’uno, e all’altro Polo,
come io vinto da duolo,
lasciando il carnal manto,
volai spirito ignudo in fra bei mirti
ch’ombrano i vaghi, e innamorati spirti.
(L. Bergalli, Componimenti poetici delle più illustri rimatrici d’ogni secolo, Venezia 1726, pp. 116-118)

