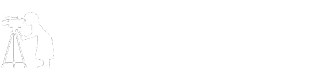Regia di Alina Marazzi
Recensione di Silvana Ferrari
Il documentario è la forma di narrazione filmica preferita da Alina Marazzi che presenta ora Vogliamo anche le rose dopo Un’ora sola ti vorrei (2002), amatissimo dal pubblico, e il meno noto Per sempre(2005).
Come nei precedenti lavori, particolare e personale è il suo modo di raccontare e di rappresentare le storie. Realizzare un documentario per Alina Marazzi vuol dire, partendo da documenti, testi, repertori, fare un’attenta, meticolosa e approfondita opera di ricerca, d’investigazione e di conoscenza della realtà, dei fatti reali, e comporli successivamente in un racconto attraverso un abile e creativo lavoro di montaggio: l’opera acquisisce così la sua struttura narrativa. In questo modo è stato progettato e girato Vogliamo anche le rose.
Tre storie di donne, fra le migliaia lette, tratte da tre diari provenienti dall’Archivio Diaristico di Pieve Santo Stefano, fanno da struttura narrante del film con le voci delle attrici Anita Caprioli, Teresa Saponangelo e Valentina Carnelutti che alle tre donne hanno prestato, oltre la voce, anche il nome: Anita, Teresa, Valentina. Siamo tra la fine degli anni sessanta e la fine degli anni settanta e nelle storie affidate all’intimità del diario, emergono paure, desideri di cambiamento, insofferenza ai rigidi legami familiari, oltre alle problematiche riguardanti la libertà sessuale e le nuove e diverse relazioni d’amore. Storie del microcosmo individuale che troveranno la cassa di risonanza, in quegli anni, nei movimenti degli studenti e soprattutto i movimenti delle donne che con le loro istanze di libertà faranno esplodere le contraddizioni di una società arcaica, dominata dal patriarcato con leggi, usi e costumi oppressivi e una severa morale sessuale.
Il diario di Anita, datato 1967, racconta di una giovane milanese alle soglie dell’università, timorosa delle scelte che nell’immediato futuro dovrà affrontare, ansiosa e inesperta della propria sessualità ancora sconosciuta, ma anche impaziente di sottrarsi all’autorità paterna; Anita sembra quasi presagire con le sue ansie e i suoi desideri il grande cambiamento che si sta avvicinando con il ’68.
Il diario di Teresa del 1975 ci porta, dalla gioiosa tenerezza di una storia d’amore appena nata, alla pesante e dolorosa scelta di un aborto clandestino, con tutte le lacerazioni psicologiche e fisiche che esso comporta, raccontato anche attraverso un tristissimo e desolante viaggio dal suo piccolo paese pugliese fino a Roma.
Il diario di Valentina del 1979 ci parla di una donna che ha fatto l’esperienza del femminismo presso la Casa delle Donne del Governo Vecchio a Roma, ha partecipato alle lotte, alle manifestazioni, alle conquiste e anche alle lunghe discussioni e agli infiniti dibattiti; la sua, delle tre, è la scrittura più problematica, più dubbiosa, con più chiaroscuri come presentisse la fine di un’epoca.
Il filo narrante dei tre diari, ridotti a sceneggiatura grazie al contributo della scrittrice Silvia Ballestra, è corredato da uno smisurato materiale di archivio, che dà a quelle piccole storie individuali una risonanza corale, un ‘estensione sociale, un respiro di Grande Storia. Gli eventi narrati sono illustrati da immagini di materiali di tipo diverso: inchieste e documentari televisivi, film indipendenti e filmini di famiglia, fotografie, animazioni, riprese di manifestazioni provenienti da archivi pubblici e privati, articoli di giornale e fotoromanzi. Un grande e paziente lavoro di ricerca unito ad un intelligente e innovativo lavoro di montaggio rendono il documentario di Alina Marazzi – e tutta la sua filmografia – un’opera originale, inusuale, internazionalmente apprezzata per la serietà nell’uso dei documenti ma anche per la genialità della loro utilizzazione.
Il lavoro di Alina Marazzi è un prezioso contributo perché la memoria della storia delle donne di quegli anni, – la generazione che oggi ha 50–60 anni -, passi alle generazioni più giovani e diventi un loro patrimonio di conoscenza e di consapevolezza di come i diritti che ora esse considerano acquisiti siano stati il frutto di lunghe e importanti lotte politiche del movimento delle donne degli anni sessanta-settanta.